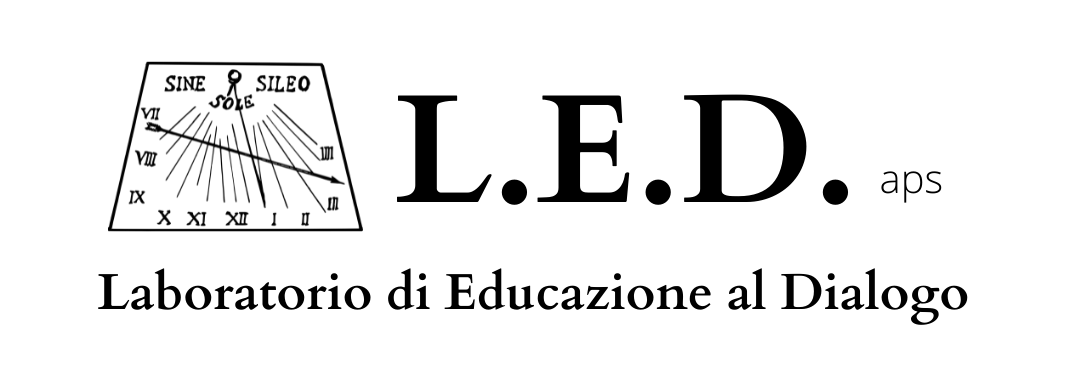Volere, o volersi bene, vuol dire anche “toccarsi”, “contattarsi”
A cura di: L. Guidolin, psicologo-psicoterapeuta
“La distanza a volte consente di sapere che cosa vale la pena tenere, e che cosa vale la pena lasciare andare”.
– Lana Del Rey
Senza esagerare nelle considerazioni relative al nostro mondo attuale, si può dire che oggi è più frequente, o si preferisce, “toccare” schermi piuttosto che “toccare”, accarezzare corpi. Promettere, giocare a nascondersi, procrastinare senza voler mai veramente incontrare l’altro, sempre protetti dal filtro di uno schermo, con ampie possibilità di fuga. Si accumulano “like”, cuoricini, emoticon di gradimento, ci si vanta di avere centinaia di amici che non si sono mai visti, né mai si vedranno. Con un tocco sulla tastiera ci si illude di poter controllare la propria vita e quella degli altri, senza “pericolosi” coinvolgimenti personali. I vari dispositivi di comunicazione digitale diventano il prolungamento di noi stessi, gli strumenti che ci danno l’illusione di poter fare della nostra vita un’opera d’arte, mostrando di noi solo ciò che desideriamo, e nascondendo il resto. “Digito ergo sum”, e pazienza se l’unica cosa che si tocca sono i tasti di un p.c. o un mouse.
Eppure la natura ci insegna che l’uomo è un animale sociale, anche perché non può fare a meno dei contatti fisici con i propri simili. Non si comunica soltanto con i segni scritti, ma anche con le mani, mani che materialmente toccano altre mani o corpi. Abbracciarsi, per esempio, è un gesto fondamentale per la nostra specie, un modo per comunicare con l’altro. E fa anche benissimo. Lo hanno spiegato i neuroscienziati: gli abbracci che derivano da motivazioni affettive fanno rilasciare una notevole quantità del cosiddetto “ormone dell’amore”, l’ossitocina, che agisce in modo benefico sul sistema cardiovascolare e immunitario. In una parola, un abbraccio potrebbe ridurre i rischi di raffreddore o fare diminuire lo stress: nei neonati – e questo è documentato – fa ridurre significativamente i casi di rigurgito di cibo.
In Cina, al contatto fisico affettivo si riconosce una tale importanza che in un asilo di Yangzhou i genitori hanno pagato 80 yuan al mese (circa 10 €) per avere garantiti, da parte delle maestre, almeno 2 abbracci al giorno per ogni singolo alunno, 1 all’entrata e 1 all’uscita.
L’abbraccio, del resto, è un’evoluzione più complessa di un gesto già presente nel mondo animale. Gli etologi sanno benissimo che sia gli uccelli che i mammiferi si abbracciano, anche se il gesto, in origine, nasce come tentativo di scaldarsi a vicenda, coprendosi reciprocamente con il corpo (= funzione di termoregolazione). In alcuni primati superiori, tuttavia, è stato fatto un passo in avanti. Tra i “colobi guereza” dell’Africa centrale, dove non c’è il pericolo di morire di freddo, l’abbraccio assume invece un significato sociale, di saluto reciproco: si tratta di una manifestazione di non-ostilità, così come il gesto delle scimmie-ragno, dalle lunghe braccia, che si allacciano per creare buoni rapporti con gruppi diversi.
Dunque, dal “bisogno” al “rito”, fino a noi, gli umani, che selezioniamo gli abbracci a seconda della loro intensità e di molte altre variabili. Il nostro cervello sembra riconoscere il contatto fisico tenero e delicato, quello che intende trasmettere sicurezza e benessere, perché gli stimoli tattili che da esso provengono prendono strade diverse, seguendo fibre nervose che le portano a zone specifiche del nostro cervello. Se un abbraccio che assomiglia ad uno strattone produce impulsi che finiscono nella corteccia somato-sensoriale, un abbraccio d’affetto o d’amore arriverà invece ad aree cerebrali legate alla sfera emotiva e sociale.
Anche negli animali accade la stessa cosa? I cinesi sembrerebbero pensarla così, visto che al “Giant Panda Protection and Research Reserve” viene pagato con il corrispettivo di 30mila €/anno un addetto per abbracciare e coccolare con frequenza i cuccioli dei panda, così da mantenerli in buona salute ed equilibrio psicofisico.
Ma c’è davvero bisogno del contatto fisico, di percepire il calore di un altro corpo vicino al nostro, o se ne può fare a meno?
I giapponesi, che sono patiti della robotica e dei surrogati tecnologici, hanno provato a creare “Hugvie”, un dispositivo di stimolazione tattile a distanza. “Hugvie” è stato realizzato da Hiroshi Ishiguro, oggi direttore del laboratorio di robotica all’Università di Osaka. Si tratta di un cuscino di vari colori, dalla forma che ricorda quella di un manichino, il quale ha dentro di sé un motore in grado di generare vibrazioni in armonia con il tono della voce di chi lo abbraccia. Questa specie di bambolotto vibrante pare abbia riscosso grande successo in Giappone. Ma l’esperimento, trasportato in Europa, precisamente in Danimarca, si è rivelato un mezzo fiasco. Alcuni spiegano la differenza del risultato con il diverso retaggio culturale: nel Paese del Sol Levante, infatti, le coccole non sono mai state così frequenti, e i nipponici non sono del tutto abituati a farne o a riceverne; per cui l’invenzione di Ishiguro è stata una piacevole novità. In Occidente, invece, l’esperimento non ha dato i risultati sperati perché gli europei preferiscono sempre e comunque abbracciare un corpo vivo, in carne ed ossa. E, ovviamente, essere anche abbracciati; cosa che una bambola non è in grado di fare con partecipazione e consapevolezza.
Spesso un abbraccio è l’unico modo per esprimere attenzione, interesse e benevolenza per chi non è in grado o soffre dell’incapacità di comunicarlo verbalmente. Pensiamo a chi sta male, a chi si trova immobilizzato in un letto d’ospedale, a chi è “ospite” di una struttura per anzianità, per malattie croniche, o degenerative, o altro: se una carezza o un abbraccio non riescono a cancellarne la sofferenza interiore o ridurne il dolore fisico, di certo ne modificano la “portata”, la “percezione”, e procurano quel minimo di sollievo che risulta essere l’unico “rimedio” a certe situazioni di sofferenza e dolore.